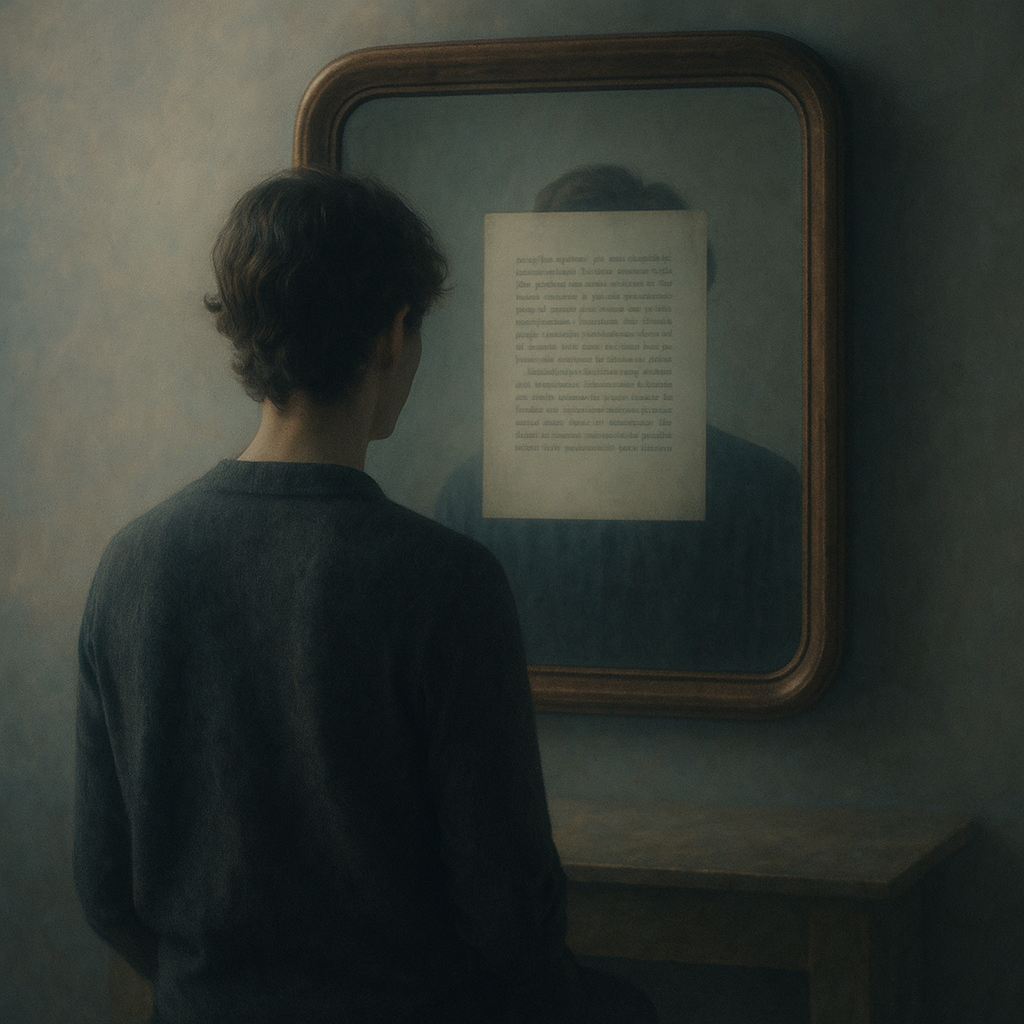Quando un verso ci “attraversa” e ci cambia? Quante volte leggiamo un testo e ci sentiamo “letti”? Quanto cambia un verso tra la prima volta che lo leggiamo e quella successiva? In questo blog post si vuole condividere un percorso personale e riflessivo, nato dalla lettura di un semplice verso di Rainer Maria Rilke, che può portare a esplorare il legame profondo tra lettura, traduzione e identità. Il testo non è mai lo stesso e nemmeno noi lo siamo.
Il “circolo ermeneutico” come esperienza viva
Partiamo da una premessa: i testi non cambiano, ma cambiano le nostre letture di essi. Hai mai pensato, ad esempio, che Giacomo Leopardi potesse essere queer? Ci è mai stato proposto, alle medie o al liceo, di riflettere su questo aspetto? Leopardi lo sapeva? O siamo noi oggi, con i nostri occhi queer, a riconoscere in lui qualcosa che allora non aveva nome? Forse. O forse è proprio questo il cuore dell’ermeneutica contemporanea: il significato non sta tutto nel testo, né tutto in noi, ma nel punto in cui ci incontriamo. Filosofi come Martin Heidegger e Hans-Georg Gadamer hanno mostrato che leggere non è mai un atto neutro: è un dialogo tra il nostro orizzonte interiore e quello dell’opera.
Definizione di “ermeneutica”: presente fin dall’antichità, il termine indica l’arte o la scienza dell’interpretazione di un testo (poetico, letterario, giuridico, religioso, ecc.). Ha assunto particolare rilevanza filosofica nel Novecento per opera delle correnti storicistiche, fenomenologiche ed esistenzialistiche (fonte: Dizionario di filosofia Treccani).
Ogni volta che rileggiamo un testo, non leggiamo più lo stesso testo. Perché non siamo più la stessa persona. Il Leopardi delle medie non è il Leopardi del liceo, né quello che incontriamo a trent’anni. Il testo rimane immobile, fermo nella sua forma. Ma noi, lettrici e lettori, cambiamo. Cresciamo, portiamo con noi nuove domande, nuove ferite, nuove “lenti” e chiavi di lettura.
E così, alcuni concetti, parole, immagini contenuti nei testi antichi – allora magari senza nome, né definizione – ci parlano oggi in modi che forse i loro autori non avrebbero mai immaginato. Non perché siano noi sbagliati adesso, ma perché li leggiamo attraverso le nostre categorie attuali, come quando riconosciamo un pensiero femminista o queer ante litteram.
Giacomo Leopardi ad Antonio Ranieri nel dicembre del 1832:
>>Ranieri mio, tu non mi abbandonerai però mai, né ti raffredderai nell’amarmi. Io non voglio che tu ti sacrifichi per me, anzi desidero ardentemente che tu provvegga prima d’ogni cosa al tuo benessere: ma qualunque partito tu pigli, tu disporrai le cose in modo che noi viviamo l’uno per l’altro, o almeno io per te; sola ed ultima mia speranza. Addio, anima mia. Ti stringo al mio cuore, che in ogni evento possibile e non possibile, sarà eternamente tuo.<<
Tradurre è interpretare. Quando le parole si “spostano”, i significati si trasformano
Basta poco perché un traduttore da “ermeneuta” si scopra “traghettatore”. Tradurre non significa semplicemente “trovare equivalenti” nella lingua di arrivo, ma decidere – parola per parola, riga per riga – cosa un testo vuole dire in quel momento, in quel contesto, per quel lettore, con quello scopo, in quella destinazione d’uso.
Già il termine tedesco “übersetzen” – che in italiano significa “tradurre” – porta con sé, nel suo etimo più antico, il senso del “portare oltre”. Tradurre è attraversare un confine. È oltrepassare. È traghettare, anche mettendo in conto il rischio di naufragare.
E Leopardi, del naufragare, la sapeva lunga:
>>E il naufragar m’è dolce in questo mare.<<
E non è un caso che l’omografo di “übersetzen” sia anche “traghettare” (“übersetzen”): condurre qualcuno da una riva all’altra. Così, senza accorgersene, una traduttrice o un traduttore diventano traghettatori e traghettatrici di significati. E con questo, anche lettori, interpreti, filosofi, testimoni, “artigiani del linguaggio”. Una moltitudine di mestieri abita chi traduce. Tradurre è entrare in una lingua con il corpo dell’altra. È ospitare, ricreare, giustificare ogni scelta. Che grande responsabilità ricade sulle traduttrici e sui tradutori!

Non tutti i “blu” in tedesco hanno la stessa “tonalità”
Concentriamoci su queste due semplici frasi in tedesco:
1) Der Himmel ist blau.
2) Ich habe heute blau gemacht.
Nella frase 1) si esprime la semplice constatazione che “il cielo è blu”, mentre nella frase 2) il concetto di “blau machen” (letteralmente “fare blu”) non ha assolutamente niente a che fare con il colore blu, bensì significa che “Oggi ho bigiato a scuola / in ufficio”. In tedesco, “blau machen” è un’espressione idiomatica colloquiale che significa prendersi un giorno libero senza giustificazione, spesso da scuola o dal lavoro, fingendosi magari malati/e.
Pertanto, non ha nulla a che fare con il colore “blu” in senso letterale. È un perfetto esempio di idiomatismo intraducibile letteralmente, e proprio per questo è utile per riflettere sul ruolo ermeneutico di una traduttrice o un traduttore.
Abbiamo esplorato insieme l’ambiguità della parola tedesca “blau” e la necessità per il traduttore di interpretare. Ogni traduzione è una lettura; ogni lettura è un atto ermeneutico: un tentativo di cogliere il senso del testo e le intenzioni di chi lo ha scritto. Il traduttore non si limita a trasportare, ma trasforma. Non copia, crea nella fedeltà.
Un verso di Rilke come specchio ermeneutico:
Ich bin du neben mir gewesen, und ich bin die Ferne, die ich mir gab
Confrontiamoci adesso con due versi rilkeiani che parlano di identità, sdoppiamento, distanza.
Ecco qui una resa ufficiale filologicamente fedele (p. es. Campi 1997) del verso rilkeiano:
Io sono stato te, accanto a me,
e sono la lontananza che mi sono dato.
La nostra personalissima resa:
Io fui te quando fuori di me ero io,
mentre io decidevo di allontanarmi quanto basta.
Un atto di traduzione? Sì. Ma anche un atto di auto-conoscenza.
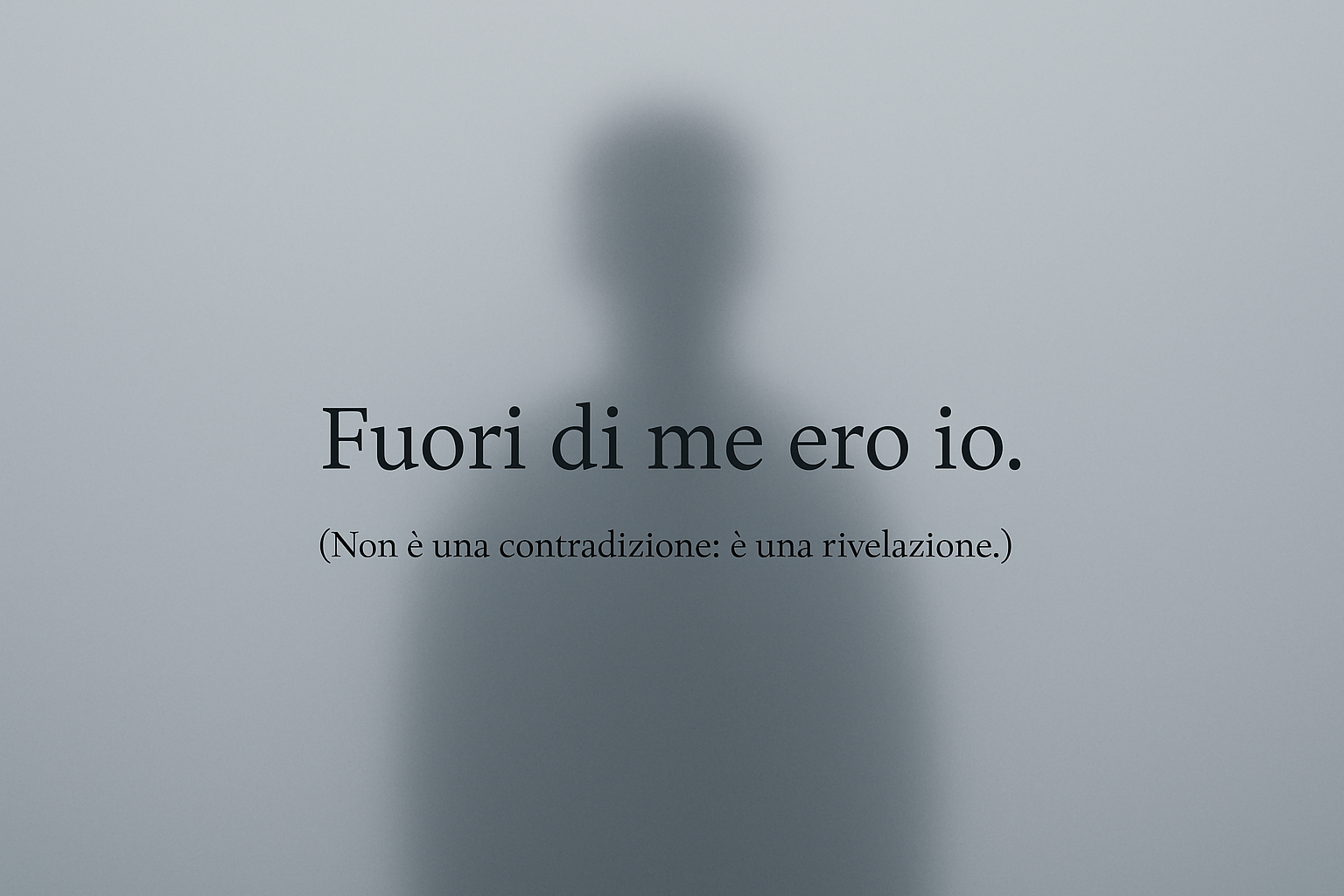
L’identità nell’alterazione
Essere se stesse/i nel momento in cui ci si perde. Una delle intuizioni più vertiginose emerse da questo dialogo interiore con Rilke è che forse si può essere veramente se stesse/i solo nel momento dell’alterazione. Quando ci si disorienta, ci si frattura, ci si confonde con l’altra persona, qualcosa di profondamente autentico può accadere. Non nella stabilità, ma nella crisi. Non nella chiarezza, ma nello smarrimento. Non nel possesso del sé, ma nella sua perdita temporanea.
Quando l’”io” si dissolve per un istante – nell’amore, nella poesia, nel dolore, nella traduzione – allora emerge un nucleo più profondo che non coincide con la coscienza ordinaria, ma la “attraversa”. “Fuori di me ero io” non è una contraddizione, è una rivelazione.
Dal testo alla vita: il lettore come co-autore ossia quando “leggere” diventa “essere”
La nostra esperienza con questi versi ha mostrato che tradurre significa anche esporsi, farsi coinvolgere, farsi toccare. Il testo non è più qualcosa da decifrare, ma una lente attraverso cui guardiamo noi stesse/i.
Come diceva Paul Ricoeur:
>>Il testo è più saggio del suo autore, e più esigente del suo lettore.<<
Letture, non risposte definitive o risolutive: l’ermeneutica come forma di libertà. Lungi dall’essere un’analisi definitiva, questo blog post vuole essere una proposta di dialogo. Ogni lettura, ogni traduzione, ogni interpretazione è una delle tante possibili, ma può diventare vera per chi la “attraversa” e la vive con autenticità.
Fusione di orizzonti
“Io fui te” è molto più di un verso: è la soglia, l’inizio di un viaggio senza meta, senza una dimora fissa a cui tornare. Nel testo, ci specchiamo. Con il testo ci trasformiamo. Attraverso il testo diventiamo altro.
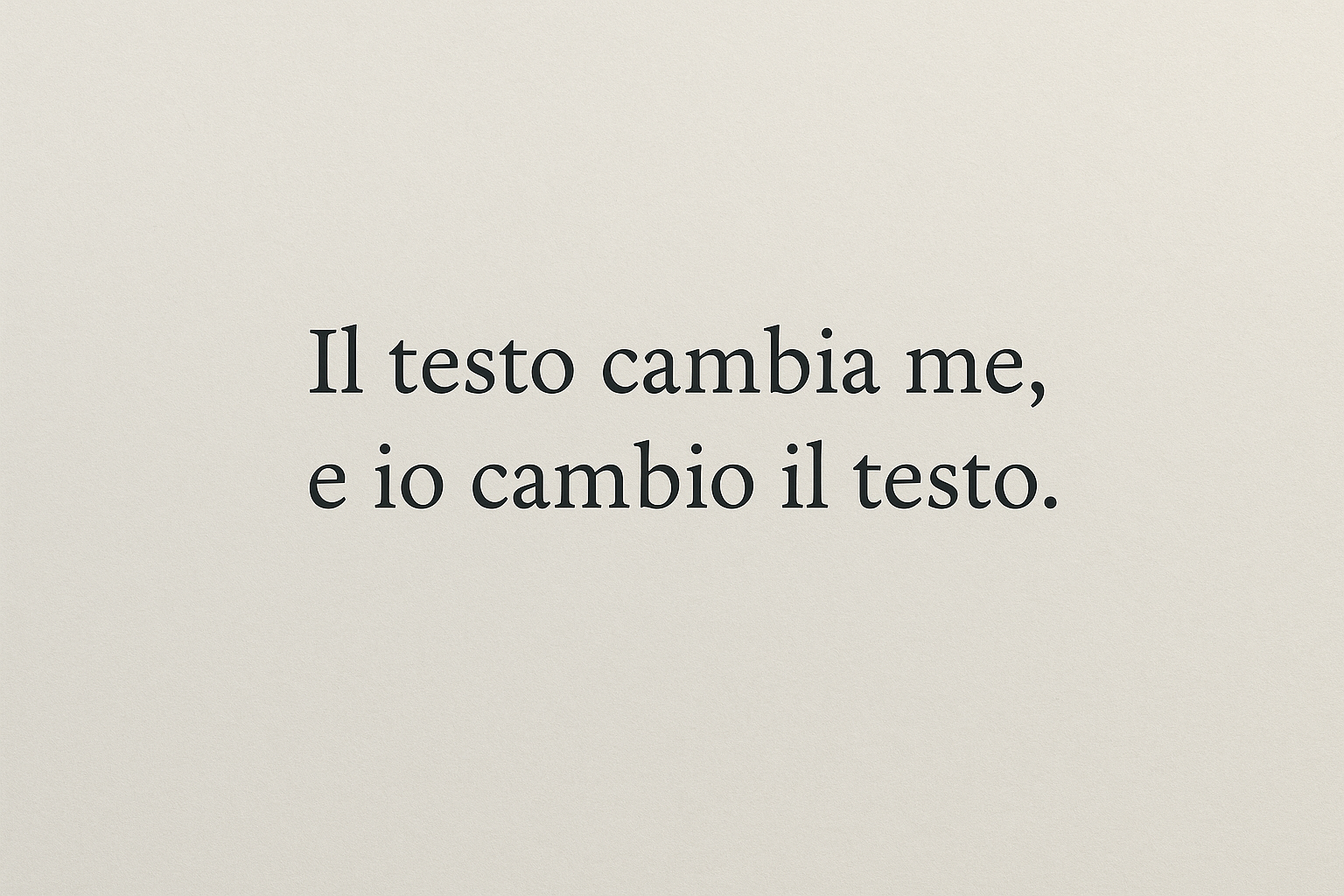
Per chi vuole approfondire 🔎
► Hans-Georg Gadamer, Verità e metodo
► Paul Ricoeur, Sé come un altro
► Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa
► George Steiner, After Babel
► Walter Benjamin, Il compito del traduttore
![[traduttore giurato.de]](https://traduttoregiurato.de/wp-content/uploads/2022/05/traduttore_giurato.de_LOGO.png)